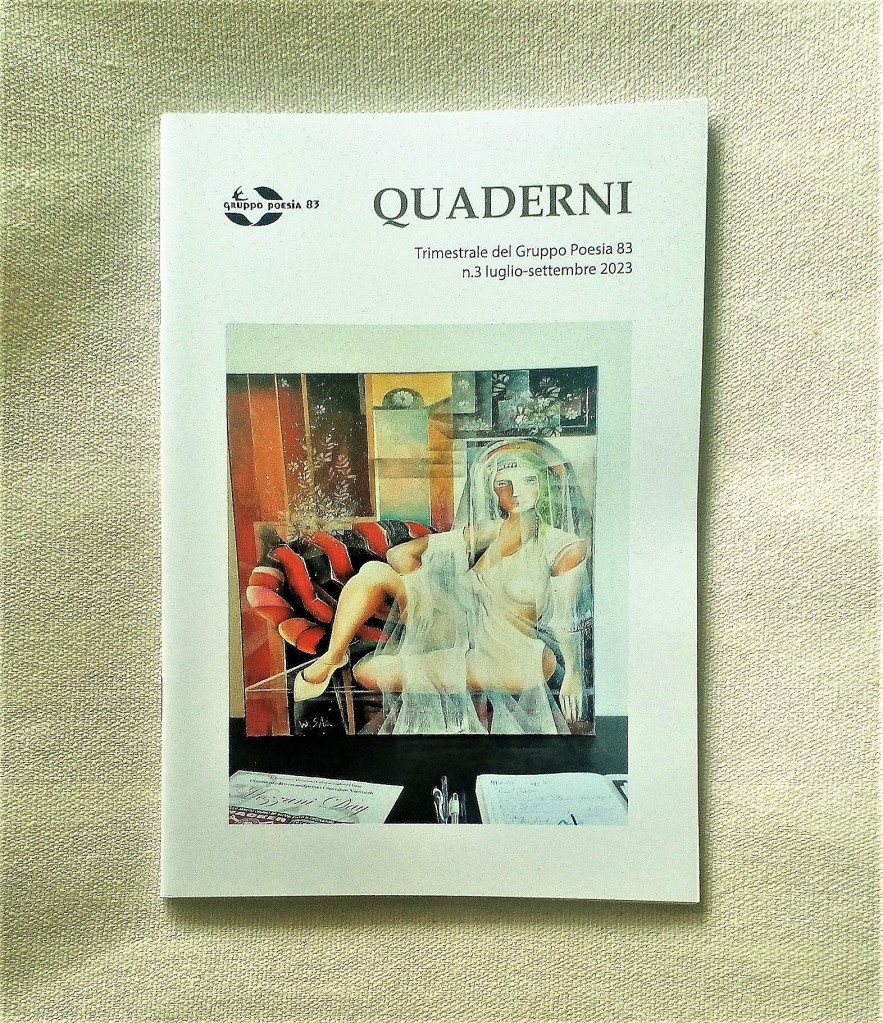Da oggi è disponibile online l’ultimo numero del trimestrale Quaderni, che si può leggere o scaricare da questa pagina

Italo Bonassi
PERCHÉ SCRIVERE POESIA?
Spesso mi viene chiesto perché scrivo in poesia, e non, ad esempio, in prosa, cos’è che mi spinge a mettere in versi quello che si potrebbe più facilmente trascrivere in esteso sino alla fine della riga, senza quell’andare ogni tanto a capo che chi non sa di poesia non capisce.
Questo “andare ogni tanto a capo” che distingue i poeti dagli altri scrittori – narratori, novellieri, romanzieri, – mi fa un po’ sorridere come definizione, in quanto paragonare i versi ad un banale susseguirsi di “andare a capo” e i versi a delle semplici righe, è piuttosto riduttivo per chi la poesia la ama e ad essa dedica la propria passione.
Pure io a volte mi domando perché non mi metta a scrivere anche in prosa, una scelta di scrittura innegabilmente più semplice – soprattutto al giorno d’oggi, dato che si tende a scrivere così come si parla, senza troppe ambizioni letterarie e tantomeno senza preziosità lessicali, ma usando il comune gergo quotidiano, che è poi anche quello scelto dalla tivù, che non si può certo definire maestra d’italiano. –
In un’intervista pubblicata sui QUADERNI del Gruppo Poesia 83 nel maggio 2010, curata dal giornalista scrittore friulano Fulvio Castellani, Lida De Polzer, squisita poetessa triestino-varesina, afferma che, in quanto ad interdipendenza tra la poesia e la prosa, in poesia esce quello che si sa già, che si intuisce o si crede di intuire, mentre la narrativa spesso è una specie di “autoanalisi involontaria”, che la porta a capire “cose che non sapeva.”
Ebbene, per me è esattamente l’incontrario: la poesia, se è tale, è introspezione, autoanalisi, ricerca di sé stessi che si redime nella sacralità della Parola, quella che rimane nascosta dentro di noi, fa parte di noi, è il nostro io che ci parla dentro.
Una Parola meditata, plasmata, anche scarnificata fino quasi all’essenziale, la Parola che parla, non la parola parlata, la ciancia.
Qui sta la differenza, per me, tra la poesia e la prosa, cioè la prosa è il linguaggio abituale di comunicazione, trascritto con un certo stile e un certo afflato di sapiente originalità, mentre la poesia – sempre che sia poesia – è ispirazione, idealizzazione, meditazione, creatività e suggestione delle intuizioni e della fantasia.
Non è vero che la poesia ti viene giù di getto, tu la pensi e la mano ti va dietro esitante, e soprattutto non è quello che già si sa, che si intuisce o si pensa di intuire. È invece quello che non si sa di avere, e che si estrae – anche con sofferenza, – parola per parola, e, una volta che ce l’hai scritta sul foglio, ne fai la vivisezione, la correggi, la scalpelli, e, s’è il caso, la muti, o la elimini e cerchi il suo sinonimo, la Parola dalla P maiuscola.
La poesia, che è puro linguaggio ma anche ragionamento, può contenere anche dell’irrazionalità, la prosa no: tant’è vero che il grande movimento ermetico del 900 ha coinvolto la poesia ma ha solo appena sfiorato la prosa. Lo stesso discorso vale per il Futurismo. Per la prosa la Parola è solo un mezzo d’informazione, per la poesia è l’informazione stessa.
Raramente uno scrittore, – che so, un romanziere, – nel descrivere un incipiente autunno, potrebbe giungere a momenti di sublime e terribilmente semplice lirismo come ad esempio Vincenzo Cardarelli quando scrive:
Autunno. Già lo sentimmo venire
nel vento d’agosto,
nelle piogge di settembre
torrenziali e piangenti,
e un brivido percorse la terra
che ora, nuda e triste,
accoglie un sole smarrito.
Ora passa e declina,
in quest’autunno che incede
con lentezza indicibile,
il miglior tempo della nostra vita
e lungamente ci dice addio.
L’arma del poeta è la metafora, come l’autunno del Cardarelli, che esprime l’idea del disfacimento della morte, un presentimento che si avverte già nelle irregolarità della stagione precedente, l’estate, con le sue prime piogge torrenziali che rinfrescano il bosco.
La prosa non ha bisogno di metafore, ma di un’abilità stilistica e di una certa maestria nel ricercare l’eleganza formale del discorso, al di là di ogni tentazione artificiosa come lo è appunto la metafora.
E soprattutto, là dove lo scrittore ha bisogno di una pagina, al poeta bastano solo due o tre “righe” ( i cosiddetti versi iniziali ):
Ognuno sta solo sul cuor della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera.
(pp.75-76 Quaderni n.2 aprile-giugno 2024)